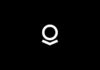A me del calcio italiano colpiscono i vuoti negli stadi italiani. La gente non si diverte più col vostro calcio. Sono troppe 20 squadre, nate tutte per vincere qualcosa e alla fine una vince e le altre restano deluse. È tutto sbagliato.
Johan Cruijff
Senza il coronavirus ci troveremmo a vivere le fasi finali della stagione, quelle decisive che vengono ricordate. Oggi al Franz Horr Stadion di Vienna si sarebbe dovuta giocare la finale di Champions League femminile, seguita una settimana dopo da quella maschile allo stadio Atatürk di Istanbul. La realtà dei fatti è che ancora siamo fermi ai quarti di finale, senza date certe di quando potremo tornare ad assistere alle partite più attese.
Nel frattempo, siamo entrati nella Fase 2 e piano piano le competizioni sportive stanno ricominciando: lo scorso weekend è ripartita la Bundesliga, il primo campionato europeo a farlo. È ripartita nello stesso modo in cui si era fermata, con un gol del giovane talento norvegese Erling Håland. Sembra che nulla, o quasi, sia cambiato. Questi due mesi di stop erano probabilmente l’occasione per cambiare un sistema che da troppo tempo non funziona, o perlomeno che tirava avanti senza più nascondere i propri difetti. La data di oggi, così significativa perché avrebbe dovuto aprire quella settimana in cui si concludono le grandi competizioni europee, è l’occasione per fare una radiografia sullo stato di salute del calcio italiano e sulle occasioni che abbiamo perso.

Le ottime prestazioni delle Azzurre, guidate da Milena Bartolini, durante i Campionati Mondiali di Francia 2019 hanno portato il movimento calcistico femminile italiano alla ribalta della cronaca nazionale. In quei giorni di giugno gli italiani seguivano le loro gesta attaccati al televisore e le vedevano schiantare, contro ogni pronostico, squadre ben più attrezzate, come Australia e Cina. L’eliminazione ai quarti di finale per mano dell’Olanda di Lieke Martens non ha intaccato la grandiosa partecipazione di una squadra che non si qualificava ai Mondiali da vent’anni esatti. L’exploit della Nazionale ha portato Sky ad acquistare i diritti televisivi per la stagione 2019/2020. Un grande risultato, per un movimento che negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente.
Uno sviluppo che è testimoniato anche da Amanda Vandervort, la massima dirigente per il calcio femminile di FIFPro, il sindacato internazionale dei calciatori, secondo la quale «fino a qualche tempo fa molte giocatrici avevano un secondo lavoro, ma ora grazie alla crescita degli ultimi anni in tante hanno puntato solo sulla carriera agonistica». In particolare, in Italia, le calciatrici vivono della loro attività, che le impegna quotidianamente con gli allenamenti. Non si può, però, parlare di contratti, in quanto ancora appartengono al mondo sportivo dilettantistico.
Questo è il motivo per cui, tra l’altro, durante la pandemia le atlete non hanno potuto accedere alla cassa integrazione. Fortunatamente, un aiuto è arrivato dal bonus di 600€ messo a disposizione da “Sport e Salute”. Un sussidio a cui possono accedere i collaboratori sportivi e le atlete che nel corso della stagione non abbiano compensi superiori ai 10.000 euro e che non abbiano altri introiti. Una misura che ha tamponato goffamente i problemi economici durante lo stop forzato, ma che lascia intatti i problemi strutturali del sistema. Per questo motivo, si rende assolutamente necessario «riscrivere la Legge ’91 sul professionismo, che è tra le priorità per costruire garanzie a chi oggi dedica la sua vita al lavoro sportivo senza essere tutelato», ha dichiarato a “Tuttocalciofemminile” Katia Serra, responsabile del settore femminile dell’AIC.
Parlando delle società, invece, è necessario effettuare una distinzione nel panorama calcistico femminile. Le squadre affiliate ad un club professionistico maschile, da una parte potrebbero risultare i primi comparti ad essere sacrificati per contenere i costi, dall’altra è però difficile pensare che proprio quei club, che hanno investito così tanto per costituire un team femminile, abbandonino dopo così pochi anni. Un discorso diverso è da fare per quelle società che oggi più di ieri si troveranno a lottare per sopravvivere. Queste squadre basano la quasi totalità dei propri introiti sui contratti di sponsorizzazione, spesso da parte di aziende locali o di brand legati a settori che in questo momento stanno soffrendo lo stop delle attività e che potrebbero arrivare a non essere in grado di rinnovare gli accordi per la stagione 2020/2021. In una nota di aprile la FIFPro invita gli organi di governo e le parti interessate a «costruire una base più solida per proteggere l’industria del calcio femminile» o sarà probabile che «la situazione attuale rappresenti una minaccia quasi esistenziale».
Paradossalmente il coronavirus è riuscito ad annullare il gap tra calcio femminile e maschile almeno su un aspetto. L’appello di FIFPro rischia infatti di infrangersi contro il muro dell’immobilità che ha impedito al mondo nel pallone, a parole così voglioso di riforme e cambiamenti, di sfruttare la pandemia per ragionare concretamente su come migliorarsi. Proprio come un giocatore in fuga verso la porta, con la metà campo avversaria totalmente sgombra, per settimane il calcio avrebbe avuto persino terreno libero per fare tutto ciò. Quanto accadeva sul fronte sanitario, infatti, aveva improvvisamente relegato i discorsi di una possibile ripresa non in secondo, bensì in terzo o quarto piano. Se c’è stata una cosa ben chiara a tutto il pubblico è stato il fatto che, in quelle circostanze, il ritorno del calcio non poteva neanche essere discusso, e forse abituarsi alla sua mancanza è stato per alcuni meno difficile di quanto previsto.

Guardando alle leghe minori del mondo professionistico maschile possiamo consolarci: siamo tornati alla normalità, tra Serie B e C si attende un’estate caotica.
Anzi, gli organi che governano il pallone nostrano hanno voluto strafare, anticipando i tempi sulla tabella di marcia con una primavera rovente in cui, tra continui ribaltamenti, è impossibile capire se e quando i campionati sospesi riprenderanno e, di conseguenza, stabilire il format della prossima stagione delle serie cadette, stabilendo promozioni e retrocessioni.
La Lega nazionale Dilettanti ha decretato le sue nove promosse, ma si annuncia una battaglia dai toni durissimi fra Federcalcio e Lega di Serie C, dopo che il Consiglio federale di mercoledì 20 maggio ha deciso di respingere la risoluzione dell’assemblea di Lega Pro, che si era espressa per la chiusura anticipata dei tre gironi. Protocolli per gli allenamenti troppo costosi e dunque inapplicabili, partite a luglio e agosto: l’estate rischia di assumere i connotati del calvario per gli ultimi tra i professionisti del nostro calcio. Alle difficoltà agonistiche si aggiungeranno quelle economiche, e si paventa già il ritorno dello spettro che si aggira per la Serie C, quello dell’allargamento. Anni a discutere invano di riduzione di numero di squadre e format sul fantomatico modello inglese ed ecco che ritorna la proposta di scorporare la terza serie in C1 e C2: bentornati anni Dieci!
Protagonista assoluto, nell’inerzia del proprio operato accompagnato dal bipolarismo delle dichiarazioni, è stato il ministro Spadafora. «Ripresa del campionato? Non se ne parla» (3 maggio), «Parola ai tecnici» (5 maggio), «Il campionato riprende tra il 13 e il 20 giugno» (10 maggio). Una versione in salsa populista del Gattopardo. Ha detto tutto e il contrario di tutto, mentre campionati e realtà del calcio minore rischiano di trasformarsi in nulla.
In definitiva, anche nel contesto descritto in precedenza, privo della pressione di dover ricominciare per forza, il calcio italiano non è riuscito a uscire da quella dimensione di una gigantesca riunione di condominio dove, ça va sans dire, il caos ha regnato indisturbato. Ricordate le tante parole che da anni venivano spese sulla necessità di ridurre il numero di squadre, di Serie A ma non solo? Seppur in modo imprevedibile, la pandemia ha esposto la più grande delle fragilità di un sistema intasato che, badiamo bene, potrebbe essere messo in tilt da qualsiasi imprevisto che agisca a medio termine. Nella sfortuna, un’occasione per ripensare finalmente il sistema, avranno pensato i più ottimisti. Invece, rigidità è stata la parola chiave per ogni dibattito finito sul tavolo o quasi.
In barba a una situazione straordinaria, chi aveva interessi da proteggere non ha fatto che arroccarsi sulle proprie posizioni. Impensabile terminare i campionati senza assegnazioni per quelle società che, come il Monza, risultavano in vantaggio nella corsa alla promozione. Poco importa che mancassero più di dieci partite, che anche altre squadre fossero in gara per gli stessi obiettivi. Certi diritti, specie se frutto di sacrifici economici, non possono essere tolti. Meglio piuttosto bloccare le retrocessioni e immaginare i prossimi campionati con qualche club in più. Ci si adatterà, ma fino a poco fa si giurava che il numero di squadre fosse uno dei primissimi fronti problematici sui quali agire.

Questo, almeno, era il punto successivo all’assemblea che il presidente di Serie C Francesco Ghirelli aveva definito «la più bella mai svolta». Peccato che due settimane dopo la FIGC ha rimesso in discussione tutto, ipotizzando lo svolgimento soltanto di playoff e playout per la terza divisione italiana, pur di riprendere a giocare.
La rigidità ha regnato anche nell’acceso dibattito tra la Lega Serie A e l’Associazione calciatori rappresentata da Damiano Tommasi, due parti capaci di inscenare un teatrino in cui a prevalere era, fin dall’inizio, la non volontà di trovare delle idee, delle soluzioni, o più semplicemente di venirsi incontro. Accade così che la prima riduzione degli stipendi accettata dai calciatori – tra i più ricchi di Serie A – venga accolta quasi con scalpore, mentre poche centinaia di chilometri più in là i club più solidi economicamente della Bundesliga (dove la discussione sugli ingaggi era stata quasi una formalità) rinunciavano a parte degli introiti dei diritti televisivi creando un fondo che sostenesse le società più in difficoltà, per cui era a rischio persino la sopravvivenza. Una proposta che, perlomeno, riconosce e tampona una delle falle più evidenti del calcio odierno, ovvero la forbice sempre più ampia che separa i top club da quelli “normali”. Anche qui, l’occasione data dalla pandemia di ragionare su un sistema le cui aziende sono nella maggior parte dei casi insostenibili si è persa tra accuse reciproche.
Nessun ragionamento sul “modello Premier” è quindi stato avviato. Il tentativo, andato in scena negli ultimi anni, di realizzare un prodotto marchiato Lega Serie A da vendere alle emittenti televisive è stato buono nelle intenzioni, ma grottesco nella realizzazione. Una scelta che avrebbe permesso di cedere i diritti tv come campionato e non come singole squadre e che avrebbe potuto portare ad una ripartizione più equa degli introiti. Invece, come sempre, il calcio italiano è stato incapace di ragionare come collettivo, perdendo ancora una volta l’occasione di rendere la Serie A più competitiva, e quindi più bella. Si prosegue con un sistema basato sul classico campanilismo italiano, nel quale ognuno è incapace di guardare oltre la staccionata che delimita il proprio orticello. Una visione che, nel caso in cui la stagione non si sarebbe potuta portare a conclusione, avrebbe messo a repentaglio la sopravvivenza di una quindicina di squadre, a causa dei circa 700 milioni di mancati introiti. Una cifra che la quasi totalità dei club aveva praticamente già speso.
Da anni la Serie A vive una situazione nella quale, spesso e volentieri, le ultime due del campionato si ritrovano a febbraio già praticamente retrocesse. Verrebbe da chiedersi, che senso ha continuare ad avere 20 squadre? Non sarebbe meglio ridurre il numero per avere un torneo in cui si alza la competitività? La riduzione a 18 squadre non sarebbe certamente la panacea di tutti i mali del calcio italiano, ma sarebbe un buon punto di partenza. Permetterebbe, innanzitutto, di evitare la presenza di club “cuscinetto” e renderebbe le partecipanti al torneo più ricche economicamente, pur partendo dal presupposto che una ridistribuzione più equa dei diritti televisivi rimane una condizione imprescindibile. Ma come sempre, la volontà di non cambiare e l’incapacità di pensare globalmente continua a farla da padrona nel panorama calcistico italiano.

È inevitabile, quindi, pensare che se non saremo in grado di ripensare il sistema, dirigendoci verso un modello sostenibile che garantisca ricchezza per tutti club ed un’aumentata competitività, la Serie A rimarrà sempre un passo indietro. Un discorso che vale per tutti i campionati continentali. E se la Premier League segna la strada e la Liga spagnola ha già intrapreso questo cammino, le nostre squadre più blasonate e forti economicamente continuano ad inseguire i top club europei. Il rischio è che qualora la cosiddetta Superlega, di cui si parla da oltre un decennio, prenda realmente corpo diventi l’approdo obbligato per le grandi italiane, per non restare relegati alla periferia del calcio europeo. Anche, ma non solo, a causa di questi due mesi, un tempo completamente perso per uno sport che diceva di voler cambiare.