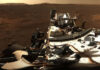La vittoria del Bologna di Sinisa Mihajlovic a San Siro ha definitivamente affossato i sogni scudetto dell’Inter, ma per una speranza che si spegne ce n’è una che prende forma. Nello specifico, le fattezze di un ragazzo di neanche diciannove anni che corre a braccia aperte dopo aver segnato il suo primo goal in serie A.
Per lui, Musa Juwara, è un sogno che si realizza, costruito con incredibile forza e determinazione. Perché a differenza di molti altri calciatori, a lui non è bastato saper giocare a calcio per arrivare a segnare a San Siro.
Ringrazio tanto il Mister che mi ha dato fiducia contro l’Inter, sono contentissimo per la mia prima rete che è dedicata alla mia famiglia e a tutti quelli che mi hanno aiutato nel mio percorso. Il merito di questa vittoria è ancora del Mister. Questo comunque per me è un sogno e una giornata del genere me la ricorderò per tutta la vita
Il viaggio di Musa

Nato a Tujereng, un piccolo villaggio del Gambia, il 26 dicembre del 2001, Musa ha ben presto capito che per avere delle possibilità nella vita avrebbe dovuto percorrere quel pericoloso viaggio della speranza che tanti, troppi esseri umani sono costretti a fare. La prima tappa obbligata è il Senegal, da lì arrivare o meno al Mediterraneo non è solo questione di determinazione ma una combinazione di fortuna, audacia e sacrifici.
Salito su un barcone da solo, pagato con il sudore del lavoro nei campi della sua famiglia, Musa è stato accolto su una spiaggia della costa messinese dalla Croce Rossa, nel giugno 2016, sulla quale era arrivato dopo essere stato raccolto da una ONG insieme a circa cinquecento altri migranti. Da lì viene mandato in un centro di accoglienza a Potenza, dove Loredana Bruno, avvocatessa del capoluogo lucano, e suo marito Vitantonio Summa, allenatore della Virtus Avigliano, decidono di diventare i suoi genitori affidatari.
Grazie a loro Musa ha potuto frequentare la scuola e, soprattutto, i campi da calcio in terra dai quali, dopo una gavetta nelle giovanili di Chievo Verona e Torino e l’esordio tra i professionisti lo scorso anno tra le fila dei clivensi, è arrivato al gol di San Siro.
Il mare come unica salvezza

Prima di Musa Juwara però altri giocatori hanno dovuto affrontare percorsi simili per arrivare a dei traguardi forse sognati ma probabilmente insperati. Alcuni hanno avuto carriere di tutto rispetto, come l’ex attaccante dell’Arsenal Christopher Wreh, primo (e finora unico) liberiano a vincere la Premier League, cresciuto insieme al più famoso cugino George Weah in una delle baraccopoli di Monrovia.
O come Rio Mavuba, nato in mezzo all’Oceano Atlantico su un barcone partito dall’Angola e diretto in Francia. Suo padre, ex calciatore che ha partecipato (senza mai scendere in campo) alla storica spedizione dello Zaire ai Mondiali del ’74, andò a giocare in Angola, si sposò e, all’inizio della guerra civile, fece quello che in molti fanno: scappano da fame, miseria e violenza per rischiare tutto in mare aperto, per una vita migliore. Le difficoltà del viaggio costrinsero la moglie incinta, Therese, a un parto prematuro circondata solo da acqua. Da qui il nome del piccolo Rio, che con una carriera di tutto rispetto è riuscito anche a partecipare a un Mondiale, quarant’anni dopo il padre.

Berahino e Moses, migranti bambini

Altri due giocatori che hanno dovuto fare i conti con guerra e traversate oceaniche sono Saido Berahino, attualmente in forze allo Zulte Waregem, e il centrocampista dell’Inter Victor Moses. Il primo, originario del Burundi, ha perso il padre durante la guerra civile e ha viaggiato da solo, a 10 anni, fino a Birmingham in Inghilterra, per ricongiungersi con la madre e i fratelli.
Lì ha trovato una nuova famiglia, il West Bromwich Albion, che ha creduto in lui fin dai primi momenti. Berahino ha giocato in tutte le formazioni minori della nazionale inglese, salvo poi decidere di indossare la casacca del Burundi, nazionale della quale è attualmente capitano.
Victor Moses invece, nato in Nigeria, è stato vittima di una guerra di religione. Suo padre, pastore cristiano, venne ucciso insieme alla moglie Josephine da un gruppo armato di estremisti islamici, quando Victor aveva 11 anni.
Il bambino riuscì letteralmente a salvarsi grazie al calcio, dato che al momento dell’agguato si trovava in strada a giocare a pallone. Pochi giorni dopo dei parenti riuscirono a mandarlo in Inghilterra, dove Victor venne accolto come richiedente asilo e iniziò la sua carriera calcistica nelle giovanili del Crystal Palace.

La grande fuga degli slavi
Altri calciatori sono fuggiti da condizioni simili, ma senza dover passare per il mare. È il caso, ad esempio, dei giocatori nati nei territori che una volta si chiamavano Jugoslavia e che sono stati terreno di morte per troppi anni. In molti sono riusciti a scappare con le famiglie prima del peggio, tanti altri sono partiti grazie al calcio e ai club europei che in quegli anni pescavano a mani basse dai campionati slavi. Molti altri però non hanno avuto “fortune” simili e sono stati costretti a spostarsi come potevano per poter raggiungere Paesi più sicuri.

È il caso di Luka Modric, uno dei più forti giocatori croati di sempre. Cresciuto in Dalmazia, la sua famiglia all’inizio della guerra d’indipendenza croata si ritrovò nel territorio sbagliato, quello nel quale l’esercito serbo seminava terrore e morte.
Dopo che il nonno Luka venne ucciso, nel dicembre 1991, la loro casa venne bruciata e i Modric scapparono a Zara, dove vennero accolti come rifugiati. Il padre del piccolo Luka riuscì a trovare lavoro come meccanico nell’esercito, i Modric vennero sistemati all’Iž Hotel, che era di fianco lo stadio. Luka Modric venne iscritto alla scuola calcio locale, il resto è storia.
L’esodo attraverso il fiume
Ma chi forse ha vissuto ancora di più lo strazio delle divisioni jugoslave è stata la generazione precedente quella di Modric. Tra i tanti campioni figli della generazione d’oro del calcio slavo che hanno calcato i campi europei (e non solo) in quegli anni, vorrei ricordare con un moto nostalgico Mario Stanic, centrocampista allievo di Ancelotti e Malesani con la storica casacca numero 13 del meraviglioso Parma degli anni’90.
Quando scoppiò la guerra Stanic, che non aveva neanche vent’anni ma che orbitava già intorno alla nazionale maggiore grazie alle ottime prestazioni con il Željezničar, si ritrovò improvvisamente senza più un posto dove andare. Come molti altri allora si recò nel nord della Bosnia e attraversò il fiume Sava, che separava una Bosnia-Erzegovina da poco indipendente dalla Croazia.
Dopo aver trovato rifugio nella città di confine di Slavonski Brod, si trasferì a Zagabria, unendosi al grande esodo di rifugiati bosniaci e croati che erano arrivati dalle zone di conflitto. Riuscì comunque a riprendere la sua carriera in Croazia, prima di scappare definitivamente dalla guerra trasferendosi in Spagna.

La lista potrebbe allungarsi a dismisura a causa dell’enorme mole di gente che, da ogni parte del mondo, è costretta a fuggire dai propri simili. Che si parli o meno di professionismo il calcio, essendo sia uno degli sport più diffusi al mondo che uno dei più semplici da replicare, è stato per molti una salvezza. Tanti ragazzi scappati da povertà, guerre e persecuzioni di vario tipo sono rinati grazie al calcio, alle possibilità di uno sport accessibile, fatto non solo di sponsor, interessi e movimenti spropositati di denaro ma anche di esseri umani che ne riconoscono l’indiscutibile valore sociale e che lo usano nel modo più nobile possibile, ovvero quello di salvare delle vite.