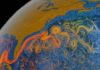Quando è cominciato il Mondiale, sulla porta di casa ho appeso un cartello che recitava: Chiuso per calcio. Quando l’ho tolto, un mese dopo, avevo giocato sessantaquattro partite, con la bottiglia di birra in mano, senza muovermi dalla mia poltrona preferita
Splendori e miserie del gioco del calcio – Eduardo Galeano

Se il grande Eduardo Galeano (Montevideo, 3 settembre 1940 – Montevideo, 13 aprile 2015) fosse ancora tra noi probabilmente il cartello “Chiuso per calcio”, questa volta, non lo avrebbe appeso. Questo è l’ultimo weekend italiano senza pallone, poi inizierà un lungo periodo di totale full immersion calcistica. Nove settimane e mezzo in cui Mickey Rourke e Kim Basinger quasi certamente verranno interpretati da Lazio e Juventus, che si contenderanno il titolo della stagione 2019-20. Discreti attori di seconda fascia lotteranno per altri obiettivi, chi per andare in Europa e chi per non retrocedere. Nel mezzo qualche comparsa è già salva e, allo stesso tempo, troppo distante dai piani nobili che garantiscono il pass europeo. Ma i verdetti di questa stagione calcistica interessano davvero a qualcuno?
Durante questa lenta ripresa del calcio, dopo il periodo più difficile di convivenza con il virus, si sono viste scene surreali. Per esempio, l’esultanza di Halaand dopo il primo gol nella Bundesliga post-Covid. I festeggiamenti a distanza e sotto le curve inesorabilmente svuotate di persone, voci, e colori. L’idea dei già tristemente noti “tifosi di cartone”, appollaiati nelle tribune degli stadi d’Europa e del mondo, è una di quelle assurde trovate con le quali, a quanto pare, dovremmo convivere ancora per lungo tempo. Ma tra le varie assurdità ce n’è una che più di tutte ha messo in luce uno spettacolo ipocrita e vergognoso.
Il 29 maggio il Salisburgo ha conquistato il primo trofeo assegnato da una federazione europea in seguito allo scoppio della pandemia. Come si può evincere dal video, i festeggiamenti della squadra, alzando al cielo la coppa nazionale austriaca, rasentano il ridicolo. Stadio deserto, distanziamento sociale tra i calciatori, speaker che annuncia (a nessuno) la vittoria del titolo, postazione dei giocatori marcate con il gessetto, i calciatori del Salisburgo che, principalmente, applaudono loro stessi, non essendoci nessun pubblico da ringraziare. Difficile che qualcuno in Italia abbia visto la finale della coppa nazionale austriaca, eppure, avendo tutti noi consumato una discreta quantità di partite nell’arco della nostra vita, possiamo senz’altro immaginare che, nei 90 minuti, il contatto fisico tra i calciatori ci sia stato. Tonnare a metà campo, contrasti, mischie su calcio d’angolo, uomini uno di fianco all’altro a formare una barriera. Ovviamente, a partita finita, tutti concentrati in un luogo chiuso come uno spogliatoio calcistico, a farsi la doccia e a cambiarsi d’abito. Davvero siamo arrivati al punto di impedire a un terzino destro di esultare insieme a un suo compagno, quando nell’azione precedente ha marcato stretto l’ala sinistra avversaria? Abbiamo concretamente bisogno di eliminare i festeggiamenti per quello che, sempre secondo Eduardo Galeano, è “l’orgasmo del calcio”, ovvero il gol?
Piaccia o no il calcio è uno sport di contatto fisico, ergo non potrebbe esistere mantenendo intatto il distanziamento sociale. Tale regola presenta un’altra conseguenza che rende il calcio post-Covid un fenomeno appartenente a una realtà distopica: la mancanza di pubblico.

Trent’anni dopo il mondiale del 1990, l’estate italiana torna ad essere calcistica. Ma quelle di quest’anno non saranno “notti magiche”. L’interrogativo è d’obbligo: è calcio vero?
La ripartenza di sabato 12 giugno sembra aver portato a compimento una parabola quarantennale del rapporto tra calcio e tifosi. Era il 1980 e il nuovo presidente della Lega Antonio Matarrese importava dal mondo anglosassone l’istituto giuridico dei “diritti televisivi in vendita”. L’estate successiva la rivoluzione delle partite in televisione prende piede con il Mundialito: un’invenzione di Silvio Berlusconi, non ancora Presidente, per portare il grande calcio su Canale 5. Un’innovazione morbida, dai tratti quasi goliardici di Cruyff che per un tempo veste la casacca del Milan, ma destinata a fare da apripista ad un processo inesorabile. La televisione prende il posto dello stadio, il tifoso diventa spettatore.
Ecco giunti alla chiusura del cerchio, o meglio dello stadio. Quello che per anni è stato un fatto isolato, quasi sempre punitivo, lo svolgimento di una partita senza tifosi per i prossimi tre mesi si accinge a essere la normalità. Certo, serve alla regolare conclusione della stagione, “ce lo chiede l’Europa”, è un messaggio importante di ripresa per il paese.
Ma non può e non deve essere la normalità, non possiamo abituarci agli stadi vuoti. Questi tre mesi di lockdown sono stati un tempo perduto per lo sport, unico ambito dello scibile umano che non ha apportato alcuna miglioria al proprio funzionamento; i prossimi tre mesi non possono diventare la definitiva sconfitta.
Ci si interroga sulla sostenibilità dello sport senza tifosi. Un po’ come chiedersi se il teatro possa andare avanti a soliloqui o la musica a prove. Senza tifosi il calcio non esiste, come il teatro senza spettatori, la musica senza ascoltatori e la letteratura senza lettori.
I tifosi non sono solo il Dodicesimo uomo in campo, sono l’ossigeno che permette al calcio di respirare. Uno stadio senza tifosi sarà anche un buon compromesso per il business, un messaggio incoraggiante per la politica, ma è un distaccamento dalla realtà.

Un po’ come chi pretende che gli eSport siano uno sport vero. In tempo di pandemia ci siamo divertiti seguendo le imprese dei 4 italiani che hanno vinto il mondiale di PES. Una trovata simpatica, se non ci fosse chi ha preso sul serio i videogiochi. Non parliamo dei milioni di più o meno giovani – tra cui gli autori dell’articolo – che alle console hanno consacrato pomeriggi, serate e spesso anche mattinate di bigiate. Parliamo del Comitato Olimpico Internazionale che ha riconosciuto gli eSport come attività sportiva nel 2017.
Battuta la concorrenza di ubriacarsi, rollare spinelli e masturbarsi, i videogiochi si sono candidati alle Olimpiadi di Parigi 2024.
Una cosa in comune gli eSports e il calcio a porte chiuse, che ci attende nei prossimi giorni, ce l’hanno: non sono sport. A entrambi manca la componente decisiva: l’elemento umano, in grado di elevare l’attività di muovere le dita su un joystick o correre dietro un pallone a sport, in un rito collettivo identitario. Con le sue miserie e i suoi splendori, ma umano, troppo umano.