Quest’anno il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, ha proposto di trasformare il 25 aprile nella giornata del ricordo per i caduti italiani di tutte le guerre, includendo quella attuale contro il Corona-virus. Non è una novità: ogni anno, nei giorni che precedono la festa della Liberazione, assistiamo a proposte più o meno creative per rinnovare, risignificare questa ricorrenza che continua ad essere percepita come irriducibilmente divisiva.

Sono passati settantacinque anni: gli ultimi testimoni ci stanno lasciando; il linguaggio della politica si è ormai spostato rispetto al fronte fascismo/comunismo, abbiamo esempi di partiti dove l’ideologia è programmaticamente negata (pensiamo ai 5stelle, oggi forza di governo); anche a livello di didattica della storia, le categorie di lettura della storia nazionale stanno cambiando, sono orientate a collocare l’Italia nel più vasto panorama europeo.
La storia della nostra Repubblica si allaccia al tempo della Resistenza come momento di fondazione, il dibattito sulla Resistenza è sempre stato un punto di riferimento nel discorso politico italiano, ma intorno a questo evento non si è mai strutturata una grande narrazione collettiva univoca e coerente. Se la Resistenza non è riducibile a una monumentalizzazione identitaria, se il 25 aprile continua ad esser percepito come una celebrazione divisiva, perché è considerata festa nazionale?
La Resistenza fu un’esperienza collettiva, fatta da persone di origine diversa, con storie diverse e diversa formazione politica (a volte addirittura nessuna), che avevano come forse unico denominatore comune l’antifascismo. L’arco di tempo che va dal settembre 1943 ai primi giorni di maggio del 1945 è un unicuum nella storia nazionale, un tempo totalmente altro tra il Ventennio fascista e l’Italia repubblicana, in cui si instaurano dialettiche politiche e sociali che rompono completamente con il passato. La Resistenza è uno spartiacque: non esisteva una repubblica italiana prima, non è mai più esistita la dittatura fascista dopo. La generazione che ha attivamente preso parte alla Resistenza era nata o cresciuta nella dittatura, si era nutrita delle immagini del fascismo, ha dovuto trovare risorse, inventare idee e linguaggi non disponibili nell’esperienza della realtà di allora.

L’elezione del 25 aprile come giorno per ricordare la libertà dal giogo nazi-fascista avvenne già nel 1946, tramite decreto, su proposta dell’allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. La scelta delle festività nazionali fu nuovamente discussa nel 1949 e il Parlamento scelse, quasi all’unanimità, di mantenere il 25 aprile. L’unico a votare contro fu il Movimento sociale italiano, fondato da reduci del fascismo e capeggiato da Giorgio Almirante, che aveva proposto invece il 20 settembre, data della breccia di Porta Pia e della presa di Roma.
Tuttavia, la volontà politica fu da subito contraddittoria: l’urgenza era archiviare il passato per andare verso una veloce riappacificazione e intraprendere un nuovo corso. Scrive lo storico Philip Cooke che «già nel 1948 la Resistenza, con le sue chiare aspirazioni a un profondo rinnovamento politico e sociale dell’Italia, era oramai un movimento prossimo alla definitiva scomparsa». Così non accadde, la Resistenza diede prova di quel che oggi definiremmo resilienza, resistette alla tentazione dell’oblio di un’Italia che voleva dimenticare per rinascere. E questo fu possibile innanzitutto grazie alle forze di sinistra, che si appropriarono del ricordo politico della Resistenza e ne fecero uno strumento identitario. La componente cattolica, che era stata ugualmente partecipe della stagione resistenziale, una volta al governo dopo aver vinto le elezioni del 1948, era più preoccupata a combattere lo spettro del comunismo che a diffondere una propria memoria sull’evento. La Resistenza diventò qualcosa che riguardava i comunisti, presto strumentalizzata sulla base delle necessità politiche del momento, profondamente influenzate dalle tensioni della Guerra Fredda.

La narrazione della Resistenza restò a lungo nelle mani di chi l’aveva combattuta: i capi della lotta di liberazione si fecero storici di loro stessi, scrissero diari e memorie. Parallelamente si muoveva il racconto letterario: «a due mesi appena dalla Liberazione nelle vetrine dei librai c’era già Uomini e no di Elio Vittorini» ci racconta Italo Calvino, che studia da vicino il fenomeno della letteratura resistenziale, oltre a scrivere, nel 1948, Il sentiero dei nidi di ragno, uno dei romanzi fondamentali di questi anni e della letteratura italiana in generale. Si afferma subito – ci dice Calvino – una retorica della Liberazione, contro la quale quella generazione straordinaria di scrittori che ha animato la cultura di quegli anni lottava. Nessuno scrittore si piega a scrivere un’epica della Resistenza, si scrivono piuttosto racconti, romanzi brevi che portano testimonianza di una fetta di umanità rotta, senza eroismi, senza il canto lirico della celebrazione.
La Resistenza nutre la letteratura di «qualcosa di nuovo e necessario», la scrittura è secca e chirurgica, l’ossessione per la narrazione oggettiva non è posa stilistica ma frutto di un’ urgenza espressiva che non poteva declinarsi diversamente. Nel 1964, nella prefazione alla terza edizione a Il sentiero dei nidi di ragno, Calvino confessa che l’unico vero romanzo della Resistenza è Una questione privata di Beppe Fenoglio, libro che porta già nel titolo la contraddittorietà, la vocazione non epica e tutta umana: «è un libro di paesaggi, ed è un libro di figure rapide e tutte vive, ed è un libro di parole precise e vere. Ed è un libro assurdo, misterioso, in cui ciò che si insegue, si insegue per inseguire altro, e quest’altro per inseguire altro ancora e non si arriva al vero perché». La letteratura più bella sulla Resistenza non sarà mai monumento nazionale, riesce invece ad anticipare alcune prospettive della storiografia più recente: è già il Partigiano Johnny (sempre Fenoglio) a parlarci di guerra civile; è Renata Viganò a raccontarci la Resistenza delle donne ne l’Agnese va a morire; è ancora Calvino a ritrarre non « i migliori partigiani, ma i peggiori possibili, un reparto tutto composto di tipi un po’ storti ».

Dalla metà degli anni Settanta si comincia a contestare il paradigma antifascista come momento fondante dell’identità nazionale, condiviso da tutti gli italiani: i giovani dei movimenti studenteschi denunciano il tradimento del potenziale rivoluzionario della Resistenza; altri, all’opposto, puntano il dito contro le derive violente dell’antifascismo e contro le componenti non-democratiche che l’avevano animato. È del 1975 la famosa Intervista sul fascismo di Renzo De Felice che, tematizzando il carattere non democratico dell’antifascismo, mette in discussione la vulgata resistenziale e inaugura la stagione del cosiddetto revisionismo. Si comincia a mettere pubblicamente in discussione il valore nazionale della Resistenza, prende piede un’incontrastabile contro-narrazione, che mira a riconoscere la legittimità della memoria dei vinti.
Tra gli anni Ottanta e la Seconda Repubblica comincia il lungo e sistematico processo di discredito della Resistenza. Prende sempre più piede nel senso comune l’idea che una falsa narrazione abbia dominato la sfera pubblica, una narrazione che è necessario revisionare. I mesi della Resistenza vengono dipinti come il regno degli eccessi, delle vendette, delle questioni private, dove la guerra di Liberazione è solo un alibi per un’indiscriminata esplosione di violenza. Sono gli anni in cui si afferma il potere prima mediatico e poi politico di Silvio Berlusconi, si inaugura una nuova egemonia culturale, espressione di nuovi interessi politici: screditare la Resistenza significava screditare tutta la Prima repubblica, che sulla Resistenza si fondava. In questo processo di revisione anti-antifascista si approda, come logica conseguenza, a una riabilitazione dell’esperienza del Fascismo: scagionato dai crimini più infamanti, come lo sterminio degli ebrei, si comincia a parlare di una dittatura all’acqua di rose, più paternalistica che repressiva. Fioriscono i vari luoghi comuni sui treni che arrivavano in orario, il Duce che avrebbe fatto anche cose buone come le pensioni e la bonifica dell’Agropontino; o ancora il Duce ottimo statista, che amava gli italiani, il cui unico vero errore sarebbe stata l’alleanza con Hitler. Memoria e oblio non sono assoluti ma selettivi: si ricorda e si dimentica ciò che è consentito e ciò che serve a modellare il mondo che vogliamo.

La polemica anti-antifascista trovò entusiastici promotori nella nuova classe politica di centro-destra, nata dopo la fine della Prima Repubblica. Torna alla ribalta l’MSI e vari personaggi politici che non nascondono una diretta filiazione dal fascismo. Interessante, in questa ridiscussione delle categorie, è la famosa svolta di Fiuggi del 1995, quando l’MSI abbandona pubblicamente i riferimenti ideologici al fascismo, per qualificarsi come forza di governo. L’accettazione dell’antifascismo da parte del movimento è però ambigua e controversa, come leggiamo nelle parole pronunciate da Gianfranco Fini in quell’occasione: «È giusto chiedere alla destra italiana di affermare senza reticenze che l’antifascismo fu un momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato. Ma è altrettanto giusto e speculare è chiedere a tutti di riconoscere che l’antifascismo non è un valore a sé stante e fondante e che la promozione dell’antifascismo da momento storico contingente a ideologia fu operata dai paesi comunisti e dal PCI per legittimarsi durante tutto il Dopoguerra.»
Nel periodo che va, indicativamente, dal 1994 al 2010 si assistite all’imporsi di un cambio di paradigma storiografico collettivo. Al termine di questo periodo l’antifascismo avrà in gran parte perduto il proprio ruolo di punto di riferimento fondamentale per l’identità storica nazionale. In questi stessi anni si afferma il gusto per una storia fatta di scandali, finte rivelazioni ed episodi truculenti. Fioriscono trasmissioni televisive e iniziative pubblicistiche che cercano il sensazionale, la versione romanzata, più che un solido rigore storiografico. Il giornalista Giampaolo Pansa è stato uno dei più famosi divulgatori di questa operazione di riscrittura: il suo libro Quello che accadde in Italia dopo il 25 aprile, pubblicato nel 2003, fu un caso editoriale senza precedenti, con oltre quattrocentomila copie vendute solo nel primo anno. Alla critica all’antifascismo proposta da Il sangue dei vinti, rispose per tutta la durata del suo mandato la “pedagogia civile” del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, intento a far crescere nel paese un “patriottismo costituzionale” fondato sul recupero della memoria della Resistenza.
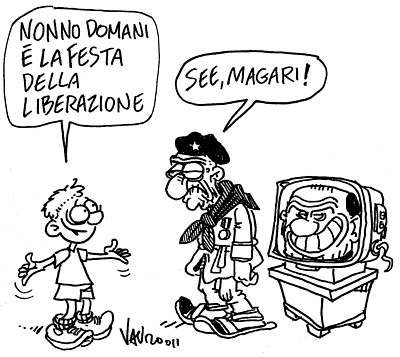
E’ curioso osservare, a proposito, come quasi mai il discorso pubblico sulla Resistenza si sia fondato sulla documentazione storiografica. Gli storici italiani, già da diversi decenni prima delle pagine di Pansa, stavano sviluppando un ricco e complesso quadro di lettura del fenomeno resistenziale, ormai liberato da qualsiasi retorica comunista anni Cinquanta. Valga come esempio, tra tanti, il libro che lo storico Claudio Pavone scrive nel 1991, Una guerra civile, che arriva a sdoganare la nozione di guerra civile, fino a quel momento usata soltanto nella pubblicistica neofascista. Tuttavia la profondità dell’indagine storiografica sembra non aver scalfito il dibattito pubblico, che ha continuato a muoversi su grandi direttrici di binomi semplificanti (buono/cattivo, giusto/sbagliato), che hanno facile presa sull’emotività, strumentale al discorso politico.
Oggi sembra che molto della carica polemica sui temi fascismo/antifascismo si sia annacquata, il ruolo stesso della storia all’interno del discorso pubblico e politico nazionale sembra piuttosto ridimensionato. Il racconto sulla Resistenza si incentra più sulle storie personali, che intrecciano la grande storia e la rendono più densa, in quella prospettiva anti retorica, anti monumentale che già la grande narrativa di Calvino, Pavese, Fenoglio o Meneghello ci offriva.

Diceva Claudio Pavone che non è possibile una memoria comune della Resistenza: «Un ex partigiano e un reduce della Rsi non potranno mai avere la stessa visione del passato. Erano italiani entrambi, ma volevano due Italie diverse, inconciliabili. Mettere una pietra sopra alle ragioni del conflitto non è un progresso né civile né storiografico». Nessuna memoria comune è mai veramente possibile, la costruzione di una memoria comune è sempre un’operazione retorica. Celebrare e avere memoria non è la stessa cosa. Celebrare è un’azione istituzionale, una cerimonia, un rito sociale che tende ad affermare e cristallizzare, che si fonda su un uso politico della storia. Avere memoria, invece, è un’operazione complessa che implica un costante dialogo tra passato e presente, dove il presente è una spinta a comprendere il passato e il passato dà strumenti per risignificare il presente. La memoria chiama in causa l’esperienza, ed è quindi per sua natura polifonica e contraddittoria.
Non è rendendo neutro il discorso sulla Resistenza che possiamo costruire una memoria inclusiva. E’ provando a raccontare e a capire la Resistenza nella sua dimensione storica, che possiamo riappropriarci del suo significato, che ogni epoca potrà rigenerare, se messo attivamente in relazione con il presente. Il movimento della Resistenza ci parla di una chiamata a responsabilità, a operare una scelta. La scelta non è mai giusta in assoluto. Se è scelta responsabile, cioè non attuata come obbedienza cieca a un codice, ma una presa in carico, una risposta a una chiamata all’azione, questa scelta responsabile sarà sempre discutibile. Ed è da questa discussione, dalla ridefinizione dei valori tramite le nostre scelte, che costruiamo la nostra appartenenza, che definiamo ciò che chiamiamo diritti o libertà. Questi valori, in democrazia, non sono dati una volta per tutte, vanno continuamente rinegoziati, reinventati e confermati. Il problema non è quindi se sia una festa di destra o di sinistra, ma è una festa in cui celebrare come momento fondante del nostro ordinamento la capacità di scelta radicale, la forza etica, la possibilità di un’azione che trovi le sue ragioni non su un passato che la garantisca ma sul sogno di un futuro che verrà.






































